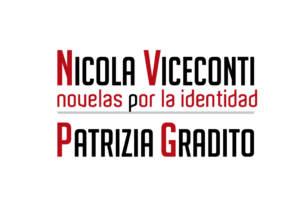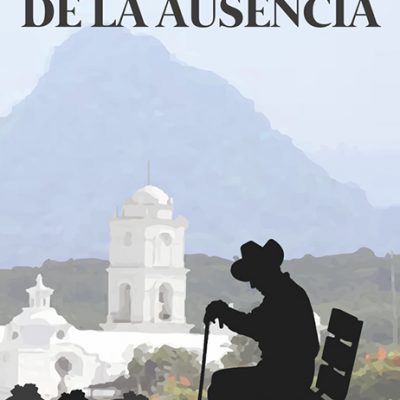Dal porto di Genova al porto di Buenos Aires
Mio padre, Giovanni Giacomo, ha più volte rievocato le avventure del viaggio che fece insieme a suo fratello dall’Italia all’Argentina, dove ad aspettarli c’era Giovanni Perfumo, mio nonno, partito da Genova prima di loro. Ogni volta che mi parlava dei suoi ricordi, la veemenza delle parole, la ricchezza delle descrizioni, il fervore e la fedeltà dei suoi racconti, mi affascinavano come se fosse la prima volta che lo ascoltavo. Era un oratore nato e la sua capacità di raccontare si alimentava nella prodigiosa memoria che conservò fino alla fine dei suoi giorni. Ricordo che era ottantenne quando recitava perfettamente pagine intere delle letture che gli aveva insegnato Overo, il suo indimenticabile maestro della scuola elementare.
Dal canto mio, posso dire di essere stato un ascoltatore privilegiato, perché fin da piccolo, ho potuto fare tesoro della inesauribile fonte delle avventure e dei ricordi che formarono la sua esperienza di vita nei quasi novant’anni di esistenza. Nelle pagine che compongono questo paragrafo cercherò di descrivere, con la maggiore fedeltà possibile, le peripezie e le vicissitudini che i due fratelli masiesi vissero durante la traversata dell’Oceano Atlantico a bordo della nave “La Plata”. Prima di affrontare questo compito, però, illustrerò quali sono state le circostanze che hanno indotto mio nonno Giovanni a prendere la decisione di emigrare con la sua famiglia in Argentina. Perché i Perfumo emigrarono in Argentina? Quando il capofamiglia Giovanni Perfumo decise di andare per la prima volta in Argentina a cercare fortuna e alleviare i bisogni crescenti della sua famiglia, lasciò a Masio, paese natale, sua moglie Margherita Milano (Nina) con i tre figli, tutti in tenera età. Questi ultimi si chiamavano, dal più grande al più piccolo: Pietro, Giovanni Giacomo, che per la sua carnagione molto scura tutti conoscevano al paese come Moro o Moretto e Giuseppe Filippo Quinto, soprannominato Pinetto.
La sua assenza durò sette anni, durante i quali lavorò sempre in Argentina, sia nei campi delle provincie di Entre Rios, Cordoba e Santa Fé, sia nella città “del Rosario”, come si chiamava un tempo, dove si era stabilito. Padre e sposo esemplare, mio nonno inviava regolarmente a Masio il denaro che risparmiava quotidianamente alla fine di durissime e interminabili giornate di lavoro. Con i suoi sacrifici riuscì ad alleviare e migliorare la situazione economica di tutta la famiglia; Nina comprò una casa più dignitosa dove andò a vivere con i figli e l’anziana madre. Un giorno, inaspettatamente, Giovanni Perfumo tornò al suo paese portando con alcuni risparmi in tasca, non molti. Le vicissitudini che affrontò mio nonno in quel lasso di tempo nell’Argentina di fine XIX secolo, e quelle che vissero contemporaneamente sua moglie ed i suoi tre figli nel lontano Masio, sono due storie parallele di sacrificio e coraggio. Di sicuro nonno Giovanni, quando tornò in Italia, aveva la certezza che vi sarebbe rimasto definitivamente. Tuttavia, tre mesi dopo essere giunto a Masio, tornò a Genova e si imbarcò per Buenos Aires per la seconda e ultima vota. Cos’era scattato nella mente di mio nonno per fargli prendere quella drastica decisione? Lo scoprii una sera d’estate quando, con i miei splendidi 20 anni, il passo leggero e il cuore contento, mi recai a far visita ai miei nonni nella loro casa di Calle Gorriti 543, nel quartiere Refineria (oggi Malvinas Argentina).
Erano soli e mi accolsero con l’allegria di sempre. Mia nonna premurosamente andò a prepararmi il mate e io restai solo con il nonno. Conservo nei cassetti dei miei ricordi tutto quello di cui parlammo quella sera lontana. Correvano i primi mesi del 1940, ed era appena scoppiata la Seconda Guerra Mondiale. Commentavamo le notizie dei giornali che, in quei giorni, stavano scuotendo l’intera umanità. Lui ricordava che nella Grande Guerra erano morti diversi giovani di Masio e tra loro alcuni Perfumo. Lo vidi preoccupato; si notava dalla seria espressione del volto, in contrasto con il suo carattere bonario ed ottimista di sempre. Non ricordo come, per allontanarlo da quei tristi pensieri, riuscii a portare la conversazione al suo primo viaggio in Argentina. Fu allora che, improvvisamente, gli domandai:
– Ditemi nonno perché avete deciso di ritornare in Argentina poco dopo essere arrivato a Masio?
Non mi rispose subito. Abbassò lo sguardo, lasciando trasparire ancora di più la sua preoccupazione. Poi cominciò a parlarmi, esprimendosi nel dialetto di Masio, che conoscevo abbastanza bene. Ancora mi sembra di sentire le sue parole
– …“Mi ricordo Ettore, che quanto tornai a Masio, dopo un’assenza di sette anni, trovai tutto uguale: molta povertà, poco lavoro, un paese fermo e la povera gente sempre perseguitata dalle necessità. Io ripresi la mia vecchia occupazione di lavoratore giornaliero nelle vigne. Un giorno, mentre stavo dissodando un vigneto, che si estendeva lungo il pendio di una collina, osservai che zappando la terra intorno alle viti, questa cadeva sulle mie scarpe prima di scivolare verso valle. Sospesi all’istante il monotono lavoro e mi soffermai a riflettere su quel particolare. Mi tirai su e mi appoggiai con entrambe le mani sul manico della zappa. Il luogo era silenzioso, non c’era nessuno intorno a me, solo filari di vite che si perdevano all’orizzonte.
Come può essere!? -pensai- dopo sette anni di sacrifici vissuti lontano dalla famiglia, sono tornato al mio paese per continuare a tirarmi la terra sui piedi, esattamente come prima. Sarà così il mio futuro, quello dei miei figli e dei figli dei miei figli? No! Non può essere. Torno in America, però questa volta con tutta la famiglia!”.
Questo fu il semplice motivo; semplice, ma trascendente, che lo fece riflettere e che cambiò radicalmente per sempre il suo destino. Per un umile lavoratore come mio nonno quel fatto banale apparve come una rivelazione: la terra che ad ogni colpo di zappa, cadeva sulle sue scarpe era un inaspettato avvertimento; un’insolita richiesta di attenzione sulla realtà della sua esistenza, fatta di stenti, senza un futuro possibile per lui e la sua famiglia, se fosse rimasto al paese.
Lasciò cadere la zappa a terra, si sedette su un ceppo lì vicino e si abbandonò ai suoi pensieri. Fu allora che si rese conto di trovarsi in un momento cruciale della sua esistenza e di dover cogliere la giusta opportunità per dare una svolta alla sua vita!
Giovanni non poteva più aspettare. Mio nonno a quel tempo aveva tutte le possibilità: il vigore della sua piena maturità, una sposa fedele e tre figli quasi adolescenti, che grazie a Dio stavano crescendo sani e forti. Aveva, inoltre, tanta voglia di lavorare, la forza per affrontare qualsiasi imprevisto e, soprattutto, il coraggio di prendere la decisione estrema di lasciare tutto: parenti, amici e la terra che lo vide nascere e farsi uomo. Avrebbe attraversato un’altra volta l’Oceano alla ricerca di nuovi orizzonti, stavolta con la sua famiglia, per stabilirsi definitivamente in una terra che aveva già cominciato ad amare. Il miracolo era compiuto! Quello stesso giorno, quando al tramonto ritornò dalle vigne, parlò a lungo con Nina. Le ragioni e le spiegazioni che le riportò erano assolutamente concrete e lei finì per riconoscere che suo marito era nel giusto. E così anche mia nonna, benché profondamente addolorata, si convinse della improrogabile necessità di abbandonare Masio e di stabilirsi in Argentina. D’altronde era quella l’unica soluzione da intraprendere per superare lo stato di povertà nel quale si trovavano. Quella sera d’estate del 1940 crebbe la mia ammirazione per quell’amato anziano, ancora vigoroso, che si esaltava nel ricordare e narrare a suo nipote, appena ventenne, un momento decisivo della sua vita. Oggi sono io, il nipote ottantenne, colui che sta scrivendo la storia dei Perfumo attraverso il ricordo e l’emozione di quella indimenticabile conversazione con mio nonno.
Fu in quel preciso momento che Giovanni e Nina presero la decisione irrevocabile di lasciare l’Italia. Il capofamiglia pianificò tutto senza perdere tempo. Avrebbe viaggiato lui per primo, imbarcandosi immediatamente per l’Argentina. Successivamente, entro lo stesso anno, avrebbe chiamato i due figli maggiori. Lavorando insieme, presto avrebbero potuto inviare i biglietti del viaggio e far emigrare il resto della famiglia. E così dopo tre mesi dal suo ritorno in Italia, Giovanni tornò al porto di Genova per imbarcarsi, su un’altra nave a vapore, verso il Rio de la Plata. Prima della fine dell’anno, come promesso, spedì a Masio i biglietti per imbarcare i figli maggiori. Anche per Pietro e Moretto arrivò il momento di intraprendere il viaggio in America. I due fratelli partono da Masio I due fratelli si apprestarono ad intraprendere il viaggio da Masio con i biglietti in mano. La prima tratta era fino al porto di Genova.
Il giorno della partenza attraversarono il paese per salutare parenti, amici e vicini di casa. Pietro aveva il dolore dipinto sulla faccia e in più occasioni i suoi occhi si riempirono di lacrime. In quei giorni si sentiva angustiato e viveva con tristezza l’avvicinarsi del fatidico momento.
Moretto, invece, felice come una Pasqua, ripeteva a tutti “Non vedo l`ora di vedere il piroscafo”.
Per capire meglio il loro viaggio in Argentina provo a fare un breve ritratto di entrambi. Al momento della partenza Pietro aveva quindici anni; era il maggiore dei figli di Giovanni e già lavorava come aiutante muratore. Di carattere tranquillo, al contrario degli altri due fratelli, Pietro era molto responsabile per la sua età, aveva chiara coscienza di quello che stava passando e capiva che quel viaggio lontano rappresentava un cambiamento importante per lui e per tutta la famiglia. Capiva anche che, partendo da Masio, si sarebbe dovuto necessariamente separare, forse per sempre, da parenti e amici, dal suo caro popolo, dalle sue strade e da un paesaggio indimenticabile, che aveva fatto da sfondo alla sua infanzia. Soprattutto era preoccupato di dover lasciare sua madre, suo fratello minore e sua nonna, con la sola speranza di poterli incontrare nuovamente in Argentina, in un futuro più o meno vicino. Al contrario, suo fratello Moretto con i suoi inquieti, indomiti e irresponsabili anni non aveva idea di quello che stava succedendo, né del viaggio che di lì a poco avrebbe dovuto intraprendere. Il suo atteggiamento era la conseguenza inevitabile di aver vissuto un lungo periodo della giovinezza senza la guida e il necessario rigore morale di suo padre, emigrato quando lui era ancora troppo piccolo.
Al momento della partenza, l’anziana nonna di Moretto fu presa da una crisi di pianto inconsolabile e mentre gli accarezzava la testa gli disse:
– “Ah, mio caro Moretto, vai in America e non ti rivedrò più!”
Lui abbracciandola le rispose:
– “ Ma no, nonna, starò cinque o sei mesi in America e poi tornerò a ca`con Pidrin e il Papà”.
Moretto non ha mai dimenticato questa triste storia, e ogni volta che la rievocava mi ripeteva:
– “E’ incredibile, ma nel dire quelle parole a mia nonna, non lo facevo per consolarla. E’ che ero realmente convinto che le cose stavano così! Stavo per intraprendere un lungo e inaspettato viaggio, senza avere la cognizione reale di quanto fosse lontana l’America da Masio”.
La valigia era già pronta. All’interno, la madre, con il cuore angustiato, aveva disposto i pochi umili vestiti che avrebbero portato con se i due ragazzi. Li chiamò entrambi e, ancora una volta, rivolse una raccomandazione a Moretto, ricordandogli di attenersi a tutte le indicazioni che gli avrebbe dato Pietro e di rimanere sempre al suo fianco durante il viaggio.
Poi, sotto lo sguardo sorpreso di entrambi, tirò fuori dalla valigia una bottiglia sigillata contenente vino Barbera, il vino che per eccellenza si produce con l’uva dei vigneti della regione di Masio. La mostrò e disse:
– “Pietro, questo vino barbera fu imbottigliato per quando avresti compiuto 20 anni, prima di partire per il servizio militare. Lo porterai nella valigia per brindare quando vi incontrerete con vostro padre in America”
Ripose nuovamente la bottiglia sotto i vestiti già sistemati nella valigia, per proteggerla da possibili urti durante il viaggio e, finalmente, con le lacrime agli occhi, abbracciò i suoi figli e li benedì. Poco dopo i due fratelli salirono su un carretto pronti per andare a Genova.
Pietro, in silenzio, si asciugò le lacrime; c’era molta tristezza nei suoi occhi. In quel momento anche Moretto era silenzioso. Il carretto partì, presto le ultime case che circondavano il villaggio scomparvero dietro il bosco. Mai più sarebbero tornati a vedere Masio.
Come imbarcavano gli emigranti italiani
I racconti che svilupperò nelle pagine che seguono fanno riferimento ai viaggi degli emigranti italiani verso diverse regioni del mondo, soprattutto verso il Sud e il Nord America. In particolare, mi riferisco all’Argentina, dalla metà del XIX alla prima decade del XX secolo, dove viaggiarono, in periodi differenti, i componenti della mia famiglia.
Sono ricordi che affiorano spontaneamente nella mia memoria, grazie a tutto quello che ho letto e a quello che ho saputo attraverso i racconti dei miei genitori. Fin da bambino, li ascoltavo estasiato ricordare le loro storie di vita, le loro esperienze maturate, dapprima nella terra che li ha visti nascere e poi in questo paese che un giorno li ha ospitati.
Queste esperienze sono state intervallate da altre: quelle vissute durante la traversata del vasto oceano, che separava i due territori e che rimasero marchiate a fuoco nella mente dei miei antenati e soprattutto nelle menti giovani di Pietro e Moretto, che poco sapevano e mai avevano visto oltre al proprio paese natale.
Lo capii ascoltando più volte mio padre nel racconto degli interminabili giorni vissuti a bordo del “La Plata” insieme a suo fratello, entrambi adolescenti, circondati costantemente da una moltitudine di emigranti, ma in una totale solitudine di affetti e mancanza di protezione.
Il periodo storico al quale mi riferisco è quello delle grandi “ondate migratorie oltreoceano”. E sebbene questo fenomeno di immigrazione massiccia dall’Europa verso l’America lo analizzerò in un altro paragrafo, credo sia opportuno descrivere il viaggio di Pietro e di Giovanni Giacomo.
Per far questo, ricorro all’ausilio di un libro intitolato “Nell’oceano”, dell’indimenticabile scrittore italiano Edmondo De Amicis (autore di “Cuore” e di “La maestrina degli operai”). Nel testo, l’autore racconta, in chiave romanzata, il viaggio che fece intorno al 1890 da Genova a Buenos Aires. Si trovava a bordo di un piroscafo a vela e a vapore, denominato “Galileo”, che trasportava passeggeri di prima, seconda e terza classe, quest’ultima con più di mille e cinquecento persone a bordo.
Con grande maestria letteraria e sottile capacità di osservazione, De Amicis tratteggia, nelle quattrocento pagine del suo libro, i vari accadimenti e le vicissitudini del viaggio. Ci sono racconti tristi, osservazioni dal tono ironico, così come riflessioni serie, suggerite di volta in volta da tutto ciò che captava il suo sguardo curioso. Si tratta del resoconto di “un viaggio oceanico di seimila miglia”.
Era povera gente, proveniente da diverse regioni d’Italia, che doveva convivere e sopportare i disagi di un’interminabile traversata, ognuno con una valigia carica di dolori e incertezze, perché sapeva di andare verso terre lontane e sconosciute.
In sintesi, “Nell’oceano” è uno dei libri di Edmondo De Amicis che conobbi già anni fa e del quale tornai a rileggere di recente alcuni dei capitoli che mi colpirono particolarmente quando lo lessi per la prima volta. Del libro vale la pena riportare un brano tratto dal primo capitolo, in cui l’autore descrive, con realismo, l’imbarco degli emigranti italiani al porto di Genova.
“L’imbarco degli emigranti”
Quando arrivai, verso sera, l’imbarco degli emigranti era già cominciato da un’ora, e il Galileo, congiunto alla calata da un piccolo ponte mobile, continuava a insaccar miseria: una processione interminabile di gente che usciva a gruppi dall’edificio dirimpetto, dove un delegato della Questura esaminava i passaporti.
La maggior parte, avendo passato una o due notti all’aria aperta, accucciati come cani per le strade di Genova, erano stanchi e pieni di sonno. Operai, contadini, donne con bambini alla mammella, ragazzetti che avevano ancora attaccata al petto la piastrina di latta dell’asilo infantile passavano, portando quasi tutti una seggiola pieghevole sotto il braccio, sacche e valigie d’ogni forma alla mano o sul capo, bracciate di materassi e di coperte, e il biglietto col numero della cuccetta stretto fra le labbra.
Delle povere donne che avevano un bambino da ciascuna mano, reggevano i loro grossi fagotti coi denti; delle vecchie contadine in zoccoli, alzando la gonnella per non inciampare nelle traversine del ponte, mostravano le gambe nude e stecchite; molti erano scalzi, e portavano le scarpe appese al collo. Di tratto in tratto passavano tra quella miseria signori vestiti di spolverine eleganti, preti, signore con grandi cappelli piumati, che tenevano in mano o un cagnolino, o una cappelliera, o un fascio di romanzi francesi illustrati, dell’antica edizione Lévy.
Poi, improvvisamente, la processione umana era interrotta, e veniva avanti sotto una tempesta di legnate e di bestemmie un branco di bovi e di montoni, i quali, arrivati a bordo, sviandosi di qua o di là, e spaventandosi, confondevano i muggiti e i belati coi nitriti dei cavalli di prua, con le grida dei marinai e dei facchini, con lo strepito assordante della gru a vapore, che sollevava per aria mucchi di bauli e di casse. Dopo di che la sfilata degli emigranti ricominciava: visi e vestiti d’ogni parte d’Italia, robusti lavoratori dagli occhi tristi, vecchi cenciosi e sporchi, donne gravide, ragazze allegre, giovanotti brilli, villani in maniche di camicia, e ragazzi dietro ragazzi, che, messo appena il piede in coperta, in mezzo a quella confusione di passeggeri, di camerieri, d’ufficiali, d’impiegati della Società e di guardie di dogana, rimanevano attoniti, o si smarrivano come in una piazza affollata. Due ore dopo che era cominciato l’imbarco, il grande piroscafo, sempre immobile, come un cetaceo enorme che addentasse la riva, succhiava ancora sangue italiano.
Così ci si imbarcava in quella epoca.
Quando ho letto per la prima volta “Nell’oceano” ero molto giovane. Il brano che ho qui riportato mi ha sempre commosso profondamente. Mi ha fatto immaginare i disagi che inevitabilmente hanno dovuto affrontare i miei nonni, i miei zii e mio padre quando, ancora bambino, dovette affrontare la traversata dell’oceano a bordo di uno di questi barconi.
Devo confessare che nessuno di loro mi raccontò di aver mai vissuto una situazione spiacevole o rischiosa al momento di imbarcarsi a Genova o durante la traversata. Più volte mio padre mi ha commentato che la vita nel “La Plata” trascorse, almeno per lui e suo fratello Pietro, senza particolari problemi.
In realtà, non poteva essere diversamente perché Nina, la madre, consapevole dei possibili pericoli che implicava affrontare quel lungo viaggio, preparò i due ragazzi, fornendo loro precisi consigli e avvertenze:
“Rispettate le istruzioni che danno le autorità a bordo della nave”
“Rispettate tutto il mondo, ma non fidatevi di nessuno”
“Per eventuali domande o problemi, parlare con i marinai, o meglio, con il commissario di bordo”.
E io mi immagino, senza timore di sbagliare, che Nina, poco prima della partenza, fece un’ultima avvertenza a suo figlio minore:
“Moretto, comportati bene e ascolta sempre a tuo fratello Pietro! “
… e una a suo figlio maggiore:
“Pietro, stai sempre attento: non perdere di vista tuo fratello Moretto”
Più volte, nel corso degli anni, mio padre avrà ricordato con un sorriso nostalgico quei preziosi consigli materni di fronte alle possibili difficoltà che potevano presentarsi durante il viaggio.
Infine, devo confessare anche alcuni episodi vissuti su “La Plata”, dei quali fu responsabile “il temerario Moretto” e ai quali mi riferirò nelle prossime pagine.
I fratelli Masiesi partono da Genova
Il giorno e l’ora della partenza erano arrivati. Il vapore “La Plata” era attraccato al molo del porto di Genova da una settimana e a mezzogiorno, con tutti i suoi passeggeri a bordo, i posti erano già esauriti. Grandi boccate di fumo nero uscivano dalla sua alta ciminiera: le caldaie avevano già raggiunto il loro livello di pressione ottimale. Tutto era pronto per trasformare la potenza del vapore in potenza meccanica, che avrebbe fatto girare l’elica, dando inizio finalmente al lungo viaggio.
I due fratelli masiesi, con i loro documenti in regola e dopo essersi sottoposti alla rituale visita medica s’imbarcarono senza contrattempi. Già prima di intraprendere il suo secondo viaggio in America, il padre gli aveva dato precise indicazioni su come dovevano cavarsela dal momento della partenza.
All’arrivo al porto di Genova, che dista 50 km dal paese, dovevano presentarsi agli uffici dell’emigrazione, Capitaneria del Porto, e mettersi in fila, come la maggior parte degli emigranti, con il passaporto in mano. Risolta la pratica d’imbarco, si sarebbero trasferiti al molo situato di fronte alla Capitaneria, per unirsi alle centinaia di emigranti che, disposti in gruppo, accedevano a una passerella mobile, appoggiata al lato della nave, attraverso la quale salivano in coperta.
Una volta a bordo il personale della nave, tutto italiano, si sarebbe incaricato di sistemarli nelle cuccette corrispondenti. Erano trascorse già quasi due ore da quando misero piede sul “La Plata”. Durante quel lasso di tempo si completò l’imbarco di tutti gli emigranti. Pietro reggeva con una mano la valigia e con l’altra stringeva fortemente la mano di suo fratello: si ricordava bene le raccomandazioni di sua madre.
Erano sommersi da una marea umana che formava un mondo strano, fluttuante, popolato di voci e grida, di risa e pianti, un mondo caotico per loro, umili abitanti di un paesello piemontese.
La crescente attività dei marinai e degli ufficiali a bordo, la severa presenza del capitano che, dal ponte di comando, osservava tutto, diede ai passeggeri la certezza che la partenza fosse imminente. Di colpo il “La Plata” lasciò udire il suono rauco e potente del suo fischio, che echeggiò nel porto. Si liberarono gli ormeggi, si alzarono le ancore, e laggiù in basso, nella sala macchine -il cuore della nave- l’albero dell’elica cominciò a girare lentamente, facendo scuotere quel mostro fluttuante di acciaio, vapore, fuoco e fumo, come se fosse un cavallo marino che, uscendo dal suo letargo, riprende vita.
Esplose il grido unanime della folla che occupava il molo. Iniziarono a sventolare fazzoletti e cappelli. Allo stesso modo, i passeggeri affacciati al parapetto della nave, risposero al saluto.
I fratelli masiesi non parteciparono a queste dimostrazioni, dove si mescolavano il tumulto dei pochi con lo sconforto e il pianto della maggior parte degli emigranti.
Nessuno era andato a salutarli. Continuavano a stare immobili e silenziosi, sempre tenendosi per mano, l’uno vicino all’altro, come se stessero cercando istintivamente una protezione reciproca. Si sentivano soli e sconcertati sulla coperta della nave, che da prua a poppa era piena di valigie, fagotti e gente che andava e veniva. A mano a mano che il “La Plata” cominciava a percorrere le prime centinaia di metri del suo lungo viaggio, allontanandosi lentamente del porto, si rinnovarono le manifestazioni di saluti.
La moltitudine di emigranti, che si trovava ammucchiata sulla banchina, poteva ammirare il superbo spettacolo che la lunga mole nera dello scafo offriva loro, mentre fendeva le acque del golfo. La nave era una grande struttura bianca, sopra la quale si notava la fumante ciminiera rossa, così come i due alberi, uno a prua e l’altro a poppa. Nel sartiame dell’albero di trincheto, come in quello di poppa, sventolavano le bandiere italiane. Era come se gli emigranti italiani del “La Plata”, che partivano portandosi con loro ricordi e tristezze, ma anche speranze, stessero salutando con un addio unanime il “suolo patria”.
La nave cominciò poco a poco ad aumentare la sua velocità e Genova si allontanò fino a diventare un punto lontano, che scomparve dietro l’orizzonte. Nel frattempo, la gente sopra coperta si andava tranquillizzando e, in un clima di relativa calma, il personale di bordo cominciò ordinatamente la sistemazione dei passeggeri. Seguendo le indicazioni, gli emigranti cominciarono a scendere per le scalette che conducevano ai compartimenti della stiva, dove c’erano i dormitori, distribuiti in vari livelli. In ogni piano c’era un corridoio centrale, dal quale si accedeva alle cuccette ubicate su entrambi i lati.
Siccome i due fratelli viaggiavano soli, ebbero la fortuna di sistemarsi in una cabina con due cuccette. Fino a quel momento Pietro non si era separato un solo istante dalla valigia, unica loro ricchezza. La perdita dei bagagli con i vestiti e la pregiata bottiglia di vino Barbera avrebbe significato un danno disastroso. Con grande accortezza la sistemò sul pavimento sopra la cuccetta inferiore. Solo allora si sentì più tranquillo. La loro ardua missione era stata compiuta.
Così cucinava mia nonna
Quando mia nonna Margherita, nel 1904, arrivò a Rosario per stabilirsi con mio nonno Giovanni e suoi quattro figli, portò con se, come un bene prezioso: una batteria da cucina che aveva ereditato da sua madre, consistente in diverse Pentole e padelle di rame di varie dimensioni, che utilizzava per cuocere alimenti nel suo paese natale e che avrebbe continuato ad usare in Argentina. Ricordo perfettamente quelle pentole: erano grandi, di rame lucido e ben conservate. Quando mia nonna, dopo averle lavate, le esponeva al sole per farle asciugare, riflettevano una luce dorata. Per me, che osservavo le cose con lo sguardo avido della giovinezza, l’esplosione di quei colori era uno spettacolo che mi affascinava. Il piatto preferito che mia nonna preparava in quelle pentole era la polenta, uno degli alimenti fondamentali della popolazione italiana di quei tempi. Chiaramente, il processo di preparazione che seguiva e la farina di mais che utilizzava erano molto diversi rispetto alle attuali forme di preparazione di questo piatto. Volendo elencare le principali differenze, vale la pena ricordare che a quei tempi l’odierna “farina di mais a cottura rapida” era sconosciuta. Inoltre, la farina di mais che usava mia nonna era macinata “grossa”, caratteristica, questa, che aggiungeva alla polenta un “corpo”, un sapore e un profumo incomparabile. Per la preparazione della polenta alla maniera classica piemontese, nonna Nina compiva un rituale con nonno Giovanni. Insieme formavano una squadra piccola, ma efficace, dove tutto era orchestrato, ma attenzione! Quella che teneva il tempo della battuta era lei, mia nonna.
Per prima cosa bisognava accendere un buon fuoco. Di questo compito si incaricava coscienziosamente mio nonno. La cucina aveva quello che si chiamava “un fogón”, ossia una stufa, costruita in muratura con due fornelli. Il combustibile utilizzato era il carbone della legna, che una volta disposto in uno dei bruciatori, veniva cosparso con un po’ di cherosene, per facilitarne la combustione. Eravamo ancora molto lontani dal lungo cammino dei cambiamenti sociali ed economici preannunciati dal progresso, che avrebbe raggiunto tutte le case, anche quelle più modeste: la stufa elettrica, l’uso del gas per cucinare e, più recentemente, il forno a microonde. Tutti apparecchi efficienti per la loro pulizia, maneggevolezza e, soprattutto, per l’assenza dei problemi di fumo.
Nelle vecchie stufe quando l’aspiratore del camino, per qualsiasi motivo non funzionava bene, il fumo, incluso il monossido di carbonio, tornava indietro e invadeva inesorabilmente tutta la cucina e la pentola sulla brace anneriva di fuliggine. Grazie a Dio, i cuochi di una volta erano audaci e non si riducevano a questo. Mentre il nonno era impegnato ad accendere il fuoco, mia nonna sceglieva la pentola da utilizzare. Dentro metteva una giusta quantità di acqua e sale e tutti gli ingredienti necessari per preparare qualsiasi tipo di ricetta che le suggeriva la propria esperienza. Quando il fuoco acquistava una certa intensità, la brace iniziava a scoppiettare e a sparare scintille incandescenti in tutte le direzioni come fuochi d’artificio in miniatura. A quel punto, donna Nina collocava la pentola con l’acqua sopra il fornello e mio nonno iniziava a sventolare energicamente il fuoco per mantenerlo vivo. Non appena cominciava a bollire l’acqua, sospendeva la sua attività di fuochista e nonna Nina entrava in scena, questa volta per affrontare un compito importantissimo: versare la farina di mais nell’acqua bollente facendo attenzione ad evitare la formazione di grumi. Ancora una volta interveniva mio nonno che con un mestolo di legno, appositamente preparato, iniziava a rimescolare la polenta.
Quell’operazione di mescolare instancabilmente la polenta aveva un motivo: se si sospendeva un solo istante, c’era il rischio di far scaldare troppo la farina e rendere il mais grumoso. Sarebbe stato un errore imperdonabile per una cuoca piemontese degna di questo nome! Per questo motivo Nina vigilava il compito di suo marito pretendendo che mescolasse la polenta per almeno venti minuti di seguito: solo così avrebbe assicurato una polenta omogenea e ben cucinata.
Completato il processo di cottura, c’era ancora una cosa da fare, quella che mi piaceva di più, perché era veramente spettacolare. Un’azione che richiedeva l’abilità e la sicurezza nei movimenti che solo mio nonno aveva.
Iniziava con il togliere la pentola dal fuoco e a poggiarla sul fornello del bancone, fatto con piastrelle rosse di ceramica francese.
Nonna Nina, nel frattempo, stendeva accuratamente sul tavolo della cucina un panno di lino bianco puro, largo circa 60 centimetri, che aveva portato dall’Italia.
Era allora il momento in cui nonno Giovanni entrava ancora una volta in scena: alzava la pentola, prendendola da entrambe le maniglie e in marcia trionfale la spostava dalla stufa al tavolo. Lì, in una straordinaria dimostrazione di abilità, dopo averla tenuta in alto per alcuni istanti, come un atleta che mostra il suo trofeo, finalmente la capovolgeva con una velocità sorprendente, depositandola, con non meno sorprendente precisione, al centro del panno bianco di puro lino italiano. Alla fine, sollevava lentamente la pentola di rame, lasciando alla vista, la fumante polenta a forma di una grande torta. Il complicato compito di mio nonno poteva sembrare conclusosi con successo, ma la vecchia nonna piemontese aveva riservato un finale da autentico spettacolo teatrale: teneva le estremità di una corda tesa sopra il centro della torta e, imprimendole un movimento ondulatorio, la inseriva nella pasta fino a quando non era perfettamente tagliata in due metà uguali. Ripeteva poi questa operazione nelle diverse angolazioni, riuscendo così a dividere la polenta in fette, pronta per essere servita, condita con burro e parmigiano. Una squisitezza totale.
Elogio alle mani di mio padre
Ricordo che da piccolo mi appassionavano le mani di mio padre, mani grandi, forti, generose, sempre pronte a stringere con sincerità la destra che gli si offriva. Ricordo le mani oneste, vigorose, tenaci, che si incallirono imparando e dopo lavorando, con speranza nei frutti futuri, la feconda terra del Sud della nostra provincia de Santa Fe, e poi nella città di Rosario. All’inizio, furono le mani giovanili di un quasi adolescente che venne dal Piemonte con la sola ricchezza dei suoi quattordici anni appena compiuti. Questo bimbo dovette apprendere e soffrire il rigore del raccolto interminabile delle spighe di grano turco, con le mani, come facevano in quegli anni, sotto un sole feroce e scottante. Ma queste mani giovanili si fecero, lungo gli anni, mani abili, forti, e così impararono a tendere fili di acciaio e fili spinosi per suddividere la terra dei campi. Lungo gli anni diventarono mani ruvide, mani sicure di un giovane che poteva sostenere le redini dei briosi cavalli di campagna che tiravano l´aratro per aprire i solchi, dopo per far seminare la terra e poi per il raccolto futuro del grano generoso, dorato, ricco…!
Dopo vennero gli anni difficili, scuri, che portarono crudeli siccità e inondazioni, le quali fecero fuggire tutti i sogni, affogarono le speranze, i progetti di mio padre contadino. Lui disse addio alla terra, alla campagna. Si stabilì con la sua famiglia nella prospera città di Rosario nel millenovecentoventi (1920).
Qui non rimasero mai mani oziose, lavorarono sempre: alzarono sacchi di grano per riempire le navi di oltre mare nel nostro porto sopra il fiume Paraná; queste mani fabbricarono milioni di mattoni e con loro costruirono forni a legna per cuocerli come facevano allora. Si fecero mani addestrate nella costruzione all´ombra dei maestri muratori venuti dall´Europa, e così costruirono. Ma, nonostante l´avventurosa vita, per le mani di mio padre ci furono ore di gioia, di creatività, perché queste mani sapevano anche accarezzare le corde del mandolino e ottenere una dolce melodia, o le corde della chitarra per potere intonare una canzone tradizionale argentina, o una canzonetta italiana accompagnato dal coro dei suoi figli. Passarono gli anni…. Quando mio padre smise di lavorare, le sue mani non rimasero oziose, poiché arricchì le sue ore da pensionato con una innata attività artistica: preparava un insieme di cemento, sabbia e acqua in proporzioni determinate e così, con attrezzi propri, modellava piccoli castelli medioevali e villaggi del suo indimenticabile paese natio, Masio, nel cuore del Piemonte. La chiesa qui esibita, è un bel modello in miniatura e uno degli ultimi lavori fatti da lui, quasi novantenne. La progettai io, la disegnai in prospettiva e lui la fece diventare realtà. Un giorno, nel lungo camminare della sua vita, quasi già novantenne, il suo cuore si fermò per sempre, e quelle mani che furono – secondo me “prodigiose” – rimasero definitivamente quiete.
La sua missione era compiuta!!!
lettera inviata al Sindaco di Masio
“Gentile Sindaco,
sperando di farle cosa gradita, Le invio una copia del racconto “Dal porto di Genova al porto di Buenos Aires” di Ettore Perfumo, tradotto e curato dal sottoscritto. Al riguardo, vale la pena di sottolineare che il mio intervento è stato svolto cercando di conservare il più possibile il sapore emotivo e nostalgico impresso nel testo dallo stesso autore, privilegiando, in tal senso, una riscrittura intenzionalmente interpretativa rispetto a quella rigorosamente letterale.
Se avessi tradotto il racconto optando per quest’ultima modalità di traduzione, infatti, avrei fornito certamente uno specchio fedele delle parole contenute nel testo, ma non avrei reso giustizia alle suggestioni poetiche che Perfumo ha sapientemente dosato in alcuni passaggi fondamentali della narrazione. Spero di essere riuscito nell’impresa e mi auguro che il breve racconto, così tradotto, riuscirà ad emozionare l’intera collettività di Masio. Era questo, d’altronde, il progetto di Ettore, forse l’ultimo, che ha espresso la sera prima di morire e al quale ha voluto che partecipassi.
La conoscenza con lo scrittore Masiese è avvenuta alcuni mesi fa per il tramite del signor Germán Vaché, un giovane di Rosario, suo amico e compagno del corso presso la scuola Italiana di Villa Hortensia in Argentina. Germán Vaché mi ha fatto conoscere le impressioni di Ettore Perfumo sul romanzo “Cumparsita”, in particolare sul capitolo “Principessa Mafalda”, dedicato al viaggio in nave degli emigranti. In effetti, la storia di fantasia del vecchio Domenico Labriola, il protagonista di “Cumparsita”, ha molte cose in comune con l’esperienza reale vissuta dai fratelli Perfumo, descritta in “Dal porto di Genova al porto di Buenos Aires”. Si tratta di vicende comuni a tanti emigranti, quelle che fanno la storia del nostro popolo che, per circa due secoli, ha “avuto il coraggio di attraversare l’oceano”. Storie di vita reali, o semplicemente frutto della fantasia, che vale sempre e comunque la pena di raccontare alle nuove generazioni per non perdere la memoria.
L’esperienza di Ettore Perfumo rappresenta senza dubbio una storia di vita che abbiamo ereditato e che dobbiamo custodire con cura per non dimenticare “quello che eravamo”. Il personale impegno nella realizzazione di un eventuale evento commemorativo a Masio è dettato unicamente dalla mia passione per l’Argentina, per la storia di un paese le cui radici sono da rintracciare nel nostro paese che molti italiani d’Argentina oggi guardano con un po’ di nostalgia”.