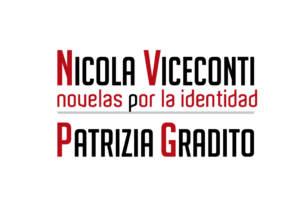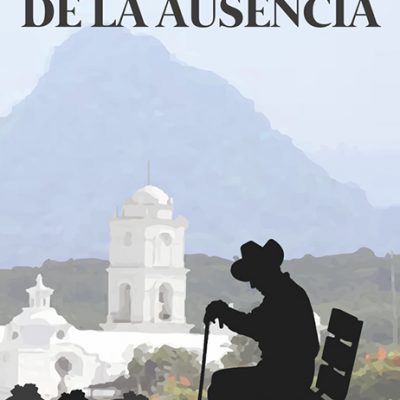Articolo pubblicato sul blog trotzdemnonostante di Lorenzo Gasparini Posted on 20/03/2014
Non so ancora dire se certe forme romanzesche – chiamate stili, canoni, forme appunto – sono fisse o meno, sono imprescindibili o no. Di certo il romanzo le prova tutte, e continua a inventarsene, eppure la classica storia di una vita sembra ancora quella forma tanto plastica e modellabile da poterne fare qualunque cosa. Tanto da sembrare, in realtà, l’unica forma romanzesca, in mille e mille variazioni possibili. Continuo a vagare nella mia libreria, trovando cose vecchie e cose nuove, alla ricerca di domande – le risposte si trovano ovunque, non sono loro la parte interessante.
* Paul Auster, Timbuctù, Torino, Einaudi, 2000, pp.158, Euro 12.91, cm 19.5×12, copertina in cartoncino e carta semiruvida di media qualità.
La trama, per sommi capi. Le avventure di un cane e del suo padrone scrittore, che poi lo lascia per altri padroni, fino al ricongiungimento finale, a Timbuctù.
Fuori l’autore. Paul Auster (Newark, USA, 1947) ha fatto un’enormità di cose di grande livello, e non ha finito. Impegnerà lettori e critici per tutto questo secolo, e non è detto sia un merito. Intanto direi di godercelo.
La recensione in senso stretto. Onestamente, devo ammettere che è molto difficile accostarsi a questo romanzo per chi, come me, ha avuto e amato molti cani. Non posso non lasciarmi andare sull’empatia, e questo rende piacevole la lettura ma meno obiettiva la recensione. Ci provo. Prima di tutto questo è un romanzo che rispetta il mandato più classico di tutti i romanzi: parlare anche della scrittura, del ruolo della letteratura. Mr. Bones è anche lui uno scrittore, come Willy, il suo unico vero padrone, anche se non lascia nulla di scritto perché non ha neanche le mani. Ma sa costruire un mondo perfettamente autosufficiente, unbildungsroman coi fiocchi, e che è anche un impietoso ritratto di una società poco attenta a chi osserva e racconta – tanto da ignorare sia gli scrittori che i cani, entrambi sistematicamente fraintesi.Sì, lo so, non l’ha scritto il cane, il romanzo – ma non è la cosa importante. Dice un critico: “in linea di massima gli americani non sanno chi sia Paul Auster e non lo leggono. Auster è estremamente popolare in Europa”. Posso solo aggiungere che, leggendo queste pagine, la mente m’è andate a Indagini di un cane di Kafka. Forse vuol dire qualcosa, forse no. In entrambi i casi abbiamo due ottimi romanzieri che tentano di stravolgere la loro e la nostra sensibilità, sfidando l’abitudine a vedere il mondo in un certo modo e filtrandolo attraverso un corpo non umano. Non mi pare poco.
Perché dovrei leggerlo. Perché anche se non avete mai avuto un cane, dovreste sapere chi è; questo libro ve ne regala la possibilità. Perché una sensibilità diversa dalla nostra può essere molto più istruttiva di cento uguali alla nostra. Perché abbiamo tutti a che fare con fenomeni letterari, quali che siano, e qui si parla di alcuni dei meno facili da individuare.
* Philip Roth, Pastorale americana, Torino, Einaudi, 2001, pp.426, Euro 9.30, cm 19.5×12, copertina in cartoncino e carta liscia di buona qualità.
La trama, per sommi capi. La vita di un uomo raccontata da uno scrittore; ma quest’ultimo si rende presto conto che il suo lavoro sarà chiamato a un compito molto difficile, perché nella vita di quell’uomo c’è qualcosa di inspiegabile che pure la condiziona completamente.
Fuori l’autore. Philip Roth è fin troppo noto per dirne qualcosa di sensato. Ha scritto abbastanza romanzi – e abbastanza diversi tra loro – per essere iscritto nella storia della letteratura mondiale, oltre che americana; e tutti, per motivi diversi, degni di attenzione e lettura anche al di là dei paroloni spesi da notissimi critici letterari. Tra i suoi meriti va ascritto anche il prendere dalla sua biografia molto materiale per quello che produce, ma sempre senza mostrare alcun compiacimento per un gesto così narcisistico. O forse è solo molto bravo a nasconderlo.
La recensione in senso stretto. Come in tutti i grandi romanzi, le circostanze storiche e geografiche sono molto ben definite – e non sono necessarie. Ciò che viene raccontato è molto americano, tradizionalmente americano e forse completamente comprensibile sono a chi vive negli USA da sempre; eppure non si fa fatica a classificarlo tra i più classici deibildungsroman mitteleuropei. La domanda alla quale tenta di rispondere questo romanzo è infatti una delle più vecchie tra i romanzi, cioè quella sul destino; ma non si tratta di conoscerlo, di scoprirlo, bensì di giudicarlo, di trovare un senso che tenga insieme tutto quello che succede. “Cos’ha la loro vita che non va?” chiede Roth alla fine di un romanzo che, coraggiosamente e coerentemente, osa concludere con una domanda. Mentre non ci viene risparmiato nessun elemento della vita vissuta che serve a distruggere un destino cercato e voluto, rimane sospeso il giudizio sul perché tutti i tentativi di costruire quella vita sensata e piena non hanno la benché minima influenza sugli eventi. Seymour Levov cerca solo una vita normale e felice, ma volerla sembra un grave oltraggio perché tutto cospira a renderlo il più infelice degli infelici. Ma non c’è nessuna cospirazione – sarebbe un senso possibile anche quello. Il testo passa per tutti i registri, ed è il classico romanzo pieno di citazioni buone come status di facebook. Che vogliate mezza pagina o due righe, ce n’è per tutti, e nessuna di queste frasi memorabili è lì per caso o gratuitamente. Quindi lo vedrete citato spesso a sproposito. Dopotutto come resistere a “l’uomo smania sempre più di far qualcosa proprio quando non gli resta più niente da fare”, o a “la gente è infallibile: sceglie quello che ti manca e poi non te lo dà”? Perché ovviamente la tragedia dello Svedese è raccontata in un classica cornice metanarrativa nella quale il protagonista è uno scrittore, quindi la riflessione sul ruolo della scrittura e sul rapporto vita-arte si respira ovunque. Ve l’avevo detto che non manca proprio niente. E’ un capolavoro? Non lo so; esiste da neanche vent’anni, mi pare presto. Ma forse è anche ora che ai romanzi si smetta di dare la sicurezza di un ruolo nella letteratura solo se sono in giro da almeno mezzo secolo.
Perché dovrei leggerlo. Perché dai tempi di Achille ed Ettore le domande sul proprio destino sono rimaste le stesse – ma è il mondo a essere cambiato, intorno. Quindi bisogna periodicamente riproporsele per tentare una risposta adeguata. Perché abbiamo incontrato tutti persone la cui vita splendeva del fulgore della buona stella, ma tutto in loro ci sapeva di stranamente misterioso, di poco coerente con quello sfavillìo. Perché bisogna sapersi spiegare il motivo per cui i nostri figli non seguono le nostre orme – qualunque cosa siano i nostri figli.
* Jack Kerouac, Sulla strada, Milano, Mondadori, 1995, pp.454, Lire 5.900, cm 17.5×10.3 , copertina in cartoncino e carta liscia di scarsa qualità.
La trama, per sommi capi. Due amici girano per gli USA quasi esclusivamente in auto, da un oceano all’altro, per trovare nella strada un modo di vita, e per visitare gli amici con i quale condividere ideali politici e umani. Inconsapevolemente, la loro amicizia finirà con i viaggi.
Fuori l’autore. Jack Kerouac (1922-1969) è Jack Kerouac. Posso solo dirvi, come al solito, che dovreste proprio leggerlo nella sua lingua originale.
La recensione in senso stretto. La storia di un’amicizia fa presto a diventare libro, se uno dei due amici è uno scrittore. Salvatore Paradiso mette in forma scritta anni di avventure vissute viaggiando per strada con il suo amico Dean Moriarty, e lo fa con una scrittura che di quella vita salva l’essenziale: il ritmo. E’ lui che impedisce ai pensieri, alle riflessioni di durare più di tanto per passare la mano alla prossima descrizione, al prossimo racconto e ai prossimi chilomerti di strada. Con gli anni questo romanzo ha acquisito ulteriore valore di testimonianza storica – “il manifesto della beat genereation” è il luogo comune – anche nella sua versione tradotta, che mostra un po’ la corda; ma mentre sfuma indietro nel tempo la sua forza eversiva (che rimane ben superiore a tanti attuali bestseller, sia chiaro) emerge un senso di conoscenza interiore molto profondo tra i personaggi; ma una conoscenza non psicologica.On the road potrebbe anche leggersi come una sorta di “manuale d’empatia”, tanto i rapporti tra personaggi si reggono su pochissime parole ma moltissimi gesti pieni di significato. In questo la scrittura di Kerouac è ancora freschissima e pronta a piacere oltre ogni interesse documentario. Se v’interessa capire in che modo un romanzo può ricreare e rendere in forma scritta un’atmosfera, On the road ci riesce.
Perché dovrei leggerlo. Perché le categorie critiche contano fino a un certo punto, per i grandi romanzi: On the road lo è, e se ne può apprezzare la forza anche senza sapere nulla della Beat Generation. Perché ben prima della sociologia e dell’urbanistica, i non luoghi (e le non esistenze che vi si svolgono) sono stati ben studiati dal romanzo, come in questo caso. Perché Sal Paradiso è lo scrittore che affronta il tipico problema di scrivere di un vissuto dove il protagonista non è lui; esattamente come noi ci troviamo spesso a vivere una vita che non è la nostra. Quando è avvenuto lo scambio? Come si può interromperlo? E qual è la vita autentica? Tante domande per un romanzo solo; ma i romanzi servono proprio per questo.
* Danilo Kiš, I leoni meccanici, Milano, Feltrinelli, 1990, pp.182, Lire 18.000, cm 19.3×12.4 , copertina in cartoncino e carta liscia di scarsa qualità.
La trama, per sommi capi. Sette racconti che formano un tutto coerente sia per l’argomento che per lo stile. Personaggi che ritornano nei vari racconti, che sono tutti asciutte cronache poliziesche, creano una piccola serie di destini accomunati dalle beffe che di loro si fa la Storia, con le vesti dello stalinismo.
Fuori l’autore. Danilo Kiš (Subotica 1935 – Parigi 1989) è stato un protagonista della letteratura centroeuropea, finché un centro Europa è esistito. Iugoslavo finché c’è stata la Iugoslavia, ha lasciato importantissimi romanzi tutti caratteristici per il loro stile asciutto e senza alcuna paura. Il leoni meccanici è stato al centro di una polemica che lo portò a emigrare in Francia. Fu anche ottimo e proficuo traduttore.
La recensione in senso stretto. Sono tempi nei quali è facile lodare chi scrive sull’ottusità del potere politico, sulla tragica comicità del destino. Non lo erano quanto lo stalinismo, nel ’78, non era proprio l’argomento più semplice da affrontare narrativamente. Lo stile asciutto e scarno di queste indagini-inchieste, di questi racconti uniti dalla stessa “cosa” di cui parlano, è necessario al tono beffardo con cui questi ritratti sono narrati; tono a sua volta necessario come adeguato contrasto alla serietà staliniana tanto cara a una certa prosa impegnata. Kiš riesce così a stare scomodo a tutti, e non a caso anche i suoi critici più favorevoli saranno costretti a emigrare. Oltre il loro argomento politico, questi racconti sono degli straordinari pezzi di bravura per sintesi ed efficacia. Le posizioni politiche e storiche si confondono e si annullano in un gioco di ripetizioni che sembra essere l’unica caratteristica fissa della Storia; si salvano quei connotati umani necessari, però, alla trasformazione della Storia in gioco ironico. Non sembra esserci via d’uscita possibile, ma ciò che rimane è solo un’amara risata. E allora, la scrittura?
Perché dovrei leggerlo. Perché a nessun testo storico sarà mai possibile parlare di un regime politico, di un sistema di potere, di una urgenza di libertà in questo modo. Perché solo il romanzo può permettersi di fare certe domande alla Storia. E di tentare delle risposte. Perché una variazione non è né un racconto né un romanzo, e forse leggendone sette una dietro l’altra si potrà capire meglio la sua natura.
* Karen Blixen, I vendicatori angelici, Milano, Bompiani, 1988, pp.366, Lire 7.000, cm 18.5×11 , copertina in cartoncino e carta ruvida di scarsa qualità.
La trama, per sommi capi. Due giovani e sfortunate amiche vagano tra Francia e Inghilterra di fine ’800 cercando di costruirsi un futuro. Dovranno lottare per la propria vita costruendosi quei princìpi che nessuno gli ha mai dato.
Fuori l’autore. Karen Blixen è uno degli pseudonimi di Karen Christentze Dinesen, baronessa von Blixen-Finecke (Rungsted 1885 – Copenaghen 1962). E’ stata una grandissima scrittrice la cui fama è stata divorata da “La mia Africa”, che – opinione personale – non è la cosa migliore che ha scritto; provate le “Sette storie gotiche”, per esempio.
La recensione in senso stretto. Il romanzo si prensenta come un classico romanzo di formazione per signorine di metà Ottocento, dato che proprio di quello va parlando. Ma qualcosa stona da subito, perché Blixen vuiole mettere alla prova sia la nostra capacità di leggere tra le righe quello che è nascosto, sia la sua capacità di costruire una metafora per un’Europa disgregata dal nazismo. Ebbene sì, tutto il romanzo non è che un’allegoria – ma non è necessario saperlo. Quello che conta è che due ragazze sole, abbandonate e diversissime possono trovare l’una nell’altra la forza di opporsi a un destino troppo grande e feroce, trovando di che ispirarsi nei propri sentimenti e nell’arte. Non c’è orrore che viene loro risparmiato, ma tutto è filtrato dalla loro intelligenza e dal loro infinito amore per la vita che si trovano a vivere, e contro questi beni dell’umana natura neanche il male più acuto può vincere. In un certo senso è un romanzo di grande speranza, dato che è stato pubblicato in un paese occupato dai nazisti; eppure, come tutti i grandi romanzi, risponde a una domanda fondamentale per l’animo umano (perché il Male non può vincere troppo a lungo?) senza usare lo stratagemma della fede, la fuga nella magia, l’illusione dell’impossibile. Per questo il suo valore va oltre le contingenze storiche nelle quali – e per le quali – è stato scritto.
Perché dovrei leggerlo. Perché i pregiudizi sui vecchi romanzi sono sempre duri a morire. Leggiamoli, punto. Perché alla fine il Bene vince sempre (o no?). Perché solo i romanzi possono assumere un forma banale ed essere rivoluzionari. Ci fanno rischiare di fare gran brutte figure.
* Nicola Viceconti, Nora Lopez – Detenuta N84, Molinella(BO), Gingko Edizioni, 2012, pp.174, Euro 14.00, cm 20.6×13.5, copertina in cartoncino plastificato con bandelle e carta liscia di media qualità.
La trama, per sommi capi. Un feroce aguzzino di desaparecidos argentini che torturò una donna viene raggiunto dalla di lei figlia, che attraversa l’oceano per cercarlo e saperne di più; ricostruiscono insieme la storia della donna, in carcere per omicidio. Non mancheranno le sorprese per entrambi, ma alla fine la verità verrà fuori. A un prezzo molto salato per tutti e due.
Fuori l’autore. Nicola Viceconti, sociologo ed esperto della comunicazione, ha deciso di interessarsi alla storia e alla società dell’Argentina, e per nostra fortuna ne parla in forma romanzesca, permettendosi una profondità e una fantasia altrimenti impossibili. Speriamo continui così.
La recensione in senso stretto. Il romanzo è diviso in due parti per affrontare i due punti di vista della vicenda, e per permettere a due voci di ricostruire la vita della protagonista, che è stata irrimediabilmente divisa in due, in un “prima” e un “dopo”. Mentre la storia si dipana e lo scopo immediato della narrazione viene raggiunto – pian piano capiamo chi è e cos’ha fatto Nora Lopez – altre domande emergono con prepotenza e non a tutte il romanzo può rispondere. Non tutte le storie possono ricomporsi, non tutti gli affetti riunirsi. La Storia non aspetta nessuno, e se il romanzo può consolarci raccontando di una possibile giustizia per qualcuno, il dolore non viene cancellato, né tutti i torti vengono riparati; rimangono sempre innocenti che pagano o colpevoli impuniti, pronti per il prossimo appuntamento con la Storia. Se e quando ci sarà.
Perché dovrei leggerlo. Per provare a capire le devastanti conseguenze sociali seguite alla questione dei desaparacidos. Perché tra romanzo e Storia il rapporto può essere strettissimo: il primo fa parlare i documenti come la seconda non potrebbe mai, ma quest’ultima sa di tragedie che nessun romanzo potrebbe mai inventare. Perché un romanzo può permettersi di dare risposte che nessuno storico si azzarderebbe a formulare, e può lasciare domande aperte là dove uno storico è obbligato a rispondere.